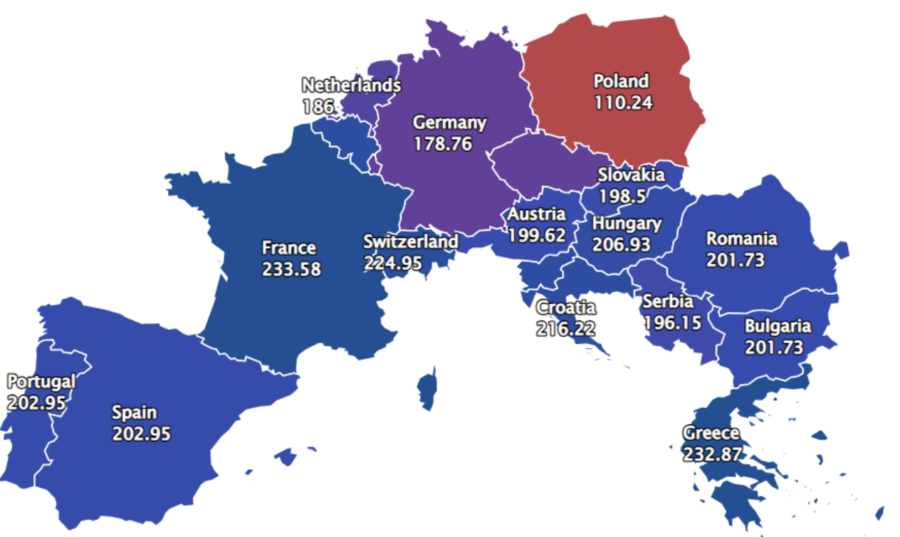C’era una volta l’ambientalismo antagonista e rivoluzionario.
Erano i primi anni ’60 e i giovani, che allora erano tanti al contrario di oggi, volevano dare un taglio con il
passato, con le contraddizioni del mondo ereditato dai genitori piccolo-borghesi.
Come tutte le generazioni volevano di più. Ed essendo nati nelle prime società ricche e protette della Storia non desideravano soltanto beni di consumo o diritti ma soprattutto libertà e purezza. Sì, purezza: quella sensazione che ti lascia il cuore leggero, ti scarica da tutte le responsabilità e ti permette di goderti in santa pace il benessere.
A quei tempi l’ambientalismo era incarnato dalle comuni, dagli hippies, dai surfisti. Un mondo spensierato.
Certo, c’erano anche gli scienziati. Ma erano pochi, ai margini della stessa comunità scientifica, percepiti da gran parte dell’opinione pubblica come fricchettoni allarmisti.
Negli anni ’70 la situazione inizia a evolvere molto rapidamente. Forse troppo.
I dati delle centraline di monitoraggio installate alla fine degli anni ’50 registrano da più di un decennio un costante aumento della concentrazione dell’anidride carbonica in atmosfera. Il primo modello climatico computerizzato, elaborato nel 1967, inizia a guadagnare notorietà e autorevolezza nella comunità scientifica. La temperatura terrestre inizia a superare le medie di riferimento, confermando la base teorica del riscaldamento globale che, fino a quel momento, mancava di riscontri incontrovertibili. Nel 1970 gli Stati Uniti istituiscono l’Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA) e l’ONU la Giornata della Terra: venti milioni di persone sfilano nelle strade delle città USA per chiedere un cambio di direzione nella politica ambientale. Nel 1972 mentre il primo shock petrolifero fa toccare con mano ad americani ed europei cosa succederebbe se si esaurissero le risorse naturali, provocando un’ondata emotiva senza precedenti.
Sfruttando il momento propizio, un piccolo gruppo di studiosi illuminati cerca di trasformare
l’ambientalismo da una subcultura in una proposta politica. Tra i protagonisti di questa fase spicca l’italiano Aurelio Peccei. Imprenditore, manager, intellettuale, Peccei è uno degli animatori del Club di Roma, un’associazione no-profit che raccoglie scienziati, economisti, politici e uomini d’affari preoccupati per il futuro dell’umanità. Nel 1972 il Club di Roma pubblica il Rapporto sui limiti dello Sviluppo, in cui lancia l’allarme: entro due decenni alcune risorse fondamentali per l’economia umana, come il petrolio,
potrebbero iniziare a scarseggiare a causa dello sfruttamento selvaggio.
I tempi per una svolta sembrano maturi ma il salto fallisce.
Nel breve termine, infatti, le previsioni si rivelano clamorosamente sbagliate.
Oggi la comunità scientifica riconosce a quelle previsioni un valore metodologico: seppur sbagliate,
impostano un il modello di valutazione della sostenibilità ambientale. Ma, ovviamente, lì per lì l’opinione
pubblica non coglie questa sottigliezza. Comprensibilmente, anche perché l’ala radicale del movimento
ambientalista conquista le luci della ribalta snocciolando certezze. L’opinione pubblica gli crede e, quando
iniziano a venire fuori le prime incongruenze si allontana sdegnata. A nessuno piace essere preso in giro,
neanche a fin di bene.
Nonostante grazie a figure rassicuranti come Al Gore la tematica ambientale rimanga viva e vitale nel
dibattito pubblico durante i due decenni successivi (’80 e ’90), sono gli anni in cui il cinema
d’intrattenimento inaugura con grande successo il filone della minaccia eco-terroristica. L’industria
cinematografica coglie, e ovviamente enfatizza, la mancanza di corrispondenza tra domanda e offerta politica: da una parte l’opinione pubblica, sempre più preoccupata, e dall’altra gli ambientalisti, percepiti
come fanatici potenzialmente pericolosi.
L’avvento del nuovo millennio segna un punto di svolta.
Il clima terrestre inizia a surriscaldarsi a tappe forzate. Anno dopo anno la temperatura globale infrange
ogni record. Le persone iniziano a sentire letteralmente sulla loro pelle gli effetti del cambiamento
climatico.
L’ambientalismo si trasforma in una proposta politica, suo malgrado.
Barack Obama si candida alla Presidenza degli Stati Uniti. È un anonimo senatore dell’Illinois, avvocato,
afroamericano, una lunga esperienza nel campo sociale. Di ambiente e clima non si è mai occupato e,
probabilmente, non ne sa neanche tanto. Ma si presenta alle elezioni con un programma che dà ampio
risalto alla tutela ambientale e alla lotta al cambiamento climatico. Perché, molto pragmaticamente, da unanparte capisce il potenziale elettorale della tematica ambientale e dall’altra comprende che non ci possiamo permettere “di lasciare in eredità ai nostri figli un mondo che non possa essere riparato”. E conquista la Casa Bianca.
Teniamolo a mente: Greta Thunberg accusa la politica di irresponsabilità e menefreghismo ma è proprio un politico di carriera che trasforma la tutela ambientale e la lotta al cambiamento climatico in priorità globali, non un ambientalista prestato alla politica.
Durante tutti e due i mandati, Obama ingaggia un confronto serrato con il mondo imprenditoriale, la
comunità scientifica e le parti sociali cogliendo un risultato sensazionale: quando lascia la Presidenza, nel
2017, ha ridotto le emissioni USA di più del 10%.
Obama riesce nell’impresa attraverso un’estenuante opera di mediazione tra interessi contrapposti:
sostiene l’industria delle rinnovabili ma anche la shale industry, il comparto petrolifero più dinamico e
innovativo. Impone una riduzione delle emissioni al settore elettrico, che aggrava la crisi dell’industria del
carbone, ma non pone limiti a quelle legate ai trasporti e ai consumi residenziali, che hanno un maggior
impatto sulla vita quotidiana. Cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’alimentazione
sostenibile ma si fa fotografare periodicamente al tavolo di un fast food, mentre consuma un hamburger
come un americano qualsiasi.
In poche parole, mette al centro del suo programma ambientale la sostenibilità politica. Sa di non essere
seduto su un trono: ogni decisione che prende deve unire piuttosto che dividere, infondere speranza invece che terrorizzare.
E in pochi anni fa vedere ai leader di tutto il mondo come si fa.
La crisi ambientale sembra finalmente instradata verso una soluzione quando sulla scena politica irrompe
l’ondata sovranista, che incorona Donald Trump Presidente degli Stati Uniti.
La situazione cambia di nuovo molto rapidamente: gli USA si sfilano dagli accordi internazionali per la lotta al cambiamento climatico (Accordi di Parigi), le emissioni americane tornano ad aumentare e la tutela sul patrimonio ambientale si allenta.
Intendiamoci: tra i tanti fattori che determinano l’ascesa di Trump ci sono anche alcuni risvolti della politica ambientale di Obama.
Nessun modello nasce perfetto e Obama sottovaluta la dimensione locale. La transizione energetica che
avvia nel Paese rende l’economia americana indubbiamente più solida e competitiva ma condanna al
declino e allo spopolamento i distretti industriali nel Nord-Est, la famosa Rust Belt. E proprio gli Stati della
Rust Belt si riveleranno decisivi nelle successive elezioni.
Il tycoon è bravo a trasformare le immagini delle miniere, delle centrali e delle fabbriche abbondonate in
simboli della deindustrializzazione americana, che negli ultimi venti anni ha vaporizzato più di 5 milioni di
posti di lavoro. In poche parole, riesce a impacchettare la deregulation ambientale, infilandola in un
discorso più ampio e condiviso.
Ma oramai la questione è davanti agli occhi di tutti, anche tra gli elettori di Trump serpeggia l’inquietudine per gli effetti del cambiamento climatico.
E infatti il Presidente cambia più volte opinione sull’argomento, tergiversa, intacca la politica ambientale
del predecessore senza avere il coraggio di smantellarla completamente. Sa che è un tema pericoloso, su
cui può perdere improvvisamente consenso anche tra il suo elettorato di riferimento.
Per sua fortuna, però, nel campo ambientalista si afferma un personaggio uguale e contrario: Greta
Thunberg.
Un fenomeno mediatico che, con la complicità di un’ampia fetta del mondo intellettuale, in pochi mesi
riporta l’ambientalismo indietro di 50 anni.
La coppia di sposini che decide di andare in viaggio di nozze negli USA o alle Maldive per vedere un “posto da film” almeno una volta nella vita deve sentirsi in colpa, perché è costretta ad andarci in aereo. Nel frattempo Greta, che non vola dal 2015 ed è una convinta sostenitrice del movimento no-flight, va negli USA con una barca a vela da regata, pilotata da uno dei rampolli della nobiltà europea. E ovviamente la coppia di sposini deve capire le circostanze, deve comprendere il sacrificio che comporta un viaggio su una barca sprovvista di ogni comfort, non deve fermarsi all’apparenza, non deve farsi strumentalizzare dalla propaganda, non deve farsi prendere dalla rabbia e dall’invidia sociale.
Il padre di famiglia che da decenni si fa rimediare la carne da un amico che vive fuori città, perché anche se costa di più è buona e genuina, dovrebbe convertirsi al tofu o agli hamburger di soia, perché sono prodotti a minor impatto ambientale. Nel frattempo Greta, che è vegana e ha fatto diventare vegana tutta la sua famiglia, vive in un Paese in cui per diversi mesi l’anno buona parte della frutta e della verdura fresca arriva in aereo, con un notevole dispendio di risorse e un drammatico impatto ambientale.
L’impiegata che guadagna 1000 euro al mese e si barcamena tra i problemi familiari e quelli di lavoro
quando regala un giocattolo o un vestito a sua figlia deve domandarsi che esempio le sta offrendo, che
educazione le sta trasmettendo. Nel frattempo Greta, che possiede solo oggetti usati o prestati perché
ripudia il consumismo, gira il mondo, si confronta con le persone più interessanti del pianeta, ha modo di
inseguire le sue aspirazioni e di condurre una vita al riparo dai bisogni materiali. E l’impiegata non deve
cadere nella trappola di pensare che, in fin dei conti, il vero benessere è proprio quello, non qualche
maglietta di H&M.
Il piccolo imprenditore che fatica a pagare stipendi e tasse, solleticato dall’idea di delocalizzare in un Paese in via di sviluppo ma restio ad abbandonare il suo Paese e i suoi operai al loro destino deve mortificarsi, perché, come dice Greta, il profitto è la benzina della crisi climatica. Nel frattempo l’adolescente, certamente suo malgrado e senza profitto personale, è diventata un fenomeno mediatico che muove fiumi di denaro. E l’imprenditore non deve convincersi che, sotto molti aspetti, la lotta il cambiamento climatico è solo un modo di fare business più evoluto del suo.
Ma chi può pensare anche solo per un istante che questa sia una proposta politica credibile, in grado di
conquistare le masse? Soprattutto, poi, in un momento come questo, in cui, la diffidenza nei confronti delle élites è palpabile e l’invidia sociale è ai massimi storici.
Ripetiamolo: il problema non è Greta, il furore e l’ingenuità dei suoi 16 anni, ma chi ha pensato di
trasformarla in un cavallo vincente nella lotta al cambiamento climatico. Chi l’ha sovraesposta mediaticamente. Chi non si fa scrupoli a far diventare un’adolescente un personaggio controverso. Tutto il circo che la strumentalizza politicamente, nel migliore dei casi, o la usa per tornaconto personale, nel peggiore.
Mentre Obama aveva compattato l’opinione pubblica, Greta con la sua intransigenza la frantuma: c’è chi
non sopporta i toni moralistici, c’è chi trova esagerato mettere in discussione le abitudini alimentari che
abbiamo ereditato dai nostri antenati, c’è chi crede che l’adolescente sia manipolata, c’è chi non condivide la retorica millenaristica, c’è chi diffida della decrescita felice, c’è chi non ci sta a farsi fare la predica da una figlia della buona borghesia svedese. E chi si trova ai margini del dibattito pubblico – la maggioranza della popolazione – percepisce solo confusione e inconcludenza invece che un indirizzo chiaro.
Con Greta l’ambientalismo abdica a un ruolo decisionale nella lotta al cambiamento climatico, proprio nel
momento in cui è tempo di agire e c’è bisogno di mettere a sistema tutti i punti di vista. Si rinchiude
nuovamente in una torre d’avorio da cui ostenta superiorità, quando non palese disprezzo, per le priorità
delle classi popolari: un buon reddito, un elevato livello di benessere materiale, garanzie per sé e per i
propri figli, più tempo libero, un’aspettativa di vita sempre più lunga.
Chi pensa che, alla fine, Greta contribuisca ad attirare l’attenzione sull’argomento, a risvegliare le
coscienze, commette lo stesso errore dell’appassionato di giardinaggio alle prime armi, che a forza di
concime fa seccare tutto il giardino. C’è un momento per seminare, un momento per concimare e un
momento per raccogliere anche in politica. E ora è il momento di raccogliere, anche perché se perdiamo
altro tempo il raccolto va a male.
Metafore a parte, continuare a sovraeccitare l’opinione pubblica come fa Greta con i suoi discorsi infuocati non la renderà più malleabile o ragionevole ma la spingerà gradualmente verso orizzonti senza speranza, verso scelte irrazionali. Quando qualcosa ci spaventa reagiamo ma se ci terrorizza o ci mette in discussione tendiamo a rassegnarci o a rimuovere, come facciamo con la morte.
Il consenso per mettere in piedi una strategia efficace di contrasto al cambiamento climatico c’è già da
tempo, come ha dimostrato Barack Obama oramai dieci anni fa. Bisogna solo saperlo intercettare, senza
alzare i toni e senza legare indissolubilmente il contrasto climatico ad altri argomenti, su cui il consenso è
molto più frammentato.
Oggi le persone hanno bisogno di sentire dire “Yes, we can” (sì, ce la possiamo fare) e di proposte alla
portata di tutti, non di ramanzine o distopie come il francescanesimo in salsa scandinava (vedi la Legge di
Jante) propugnato da Greta.