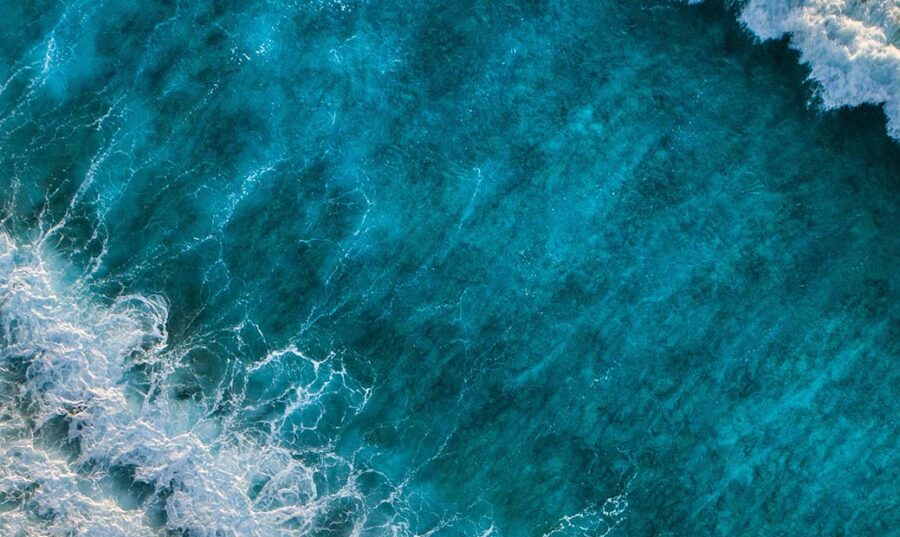Nelle ultime due settimane il prof. Romano Prodi ha cercato di instillare un po’ di pessimismo della ragione nel dibattito sulla crisi ambientale, dominato da uno stucchevole ottimismo della volontà che nasconde all’opinione pubblica gli aspetti meno gradevoli ed edificanti della transizione verso le energie rinnovabili.
Con la consueta pacatezza, il Professore ricorda che, nonostante gli imponenti sforzi compiuti negli ultimi anni, eolico e fotovoltaico rappresentano ancora il 2% della produzione energetica mondiale; sottolinea come l’Italia sia fuori dalla filiera delle rinnovabili, in mano ai Paesi del nord Europa e alla Cina; mette in guardia l’Europa riguardo ai rischi di deindustrializzazione legati alla transizione ecologica; suggerisce che, se almeno una parte del petrolio e del gas che consumiamo la producessimo a casa nostra, potremmo pretendere standard ambientali molto più rigorosi dall’industria estrattiva; ricorda che, se lasciamo il coordinamento con la Cina all’asse Parigi-Berlino, non ci dobbiamo stupire che Francia e Germania perseguano i loro interessi nazionali invece di quelli italiani.
Temi che riecheggiano da tempo nel dibattito specialistico, e che abbiamo trattato tante volte su Econopoly, ma che non riescono a penetrare la cortina fumogena con cui gli ambientalisti ortodossi hanno avvolto il dibattito pubblico.
Ma, mentre ci accapigliamo sul prezzo dell’energia o sull’intermittenza delle fonti rinnovabili, ci siamo dimenticati che la transizione ecologica non è solo un gigantesco affare attorno a cui ruotano montagne di denaro.
I veri buchi neri della nostra politica ambientale, infatti, sono di natura etica e strategica, non economica.
È proprio in questi due ambiti che sfruttando la complessità del tema e l’emotività del momento sono stati omessi all’opinione pubblica pezzi importanti del puzzle ambientale.
Facciamo qualche esempio.
Tre quarti del mercato petrolifero globale è controllato da compagnie nazionalizzate (National Oil Companies, NOCs) e solo un quarto è in mano alle famigerate multinazionali del petrolio. Più della metà della produzione mondiale di greggio, inoltre, proviene da Paesi in via di sviluppo. Tutto sommato, perciò, parliamo di un mercato democratico, che dà da mangiare a un quarto della popolazione mondiale.
I Paesi più esposti alla fine della Oil Age sono economie in via di sviluppo
Al contrario, la produzione di pannelli fotovoltaici, pale eoliche e batterie si concentrerebbe nelle mani di un pugno di economie avanzate, con adeguate capacità tecnologiche e industriali. In poche parole, stiamo progettando una transizione energetica che nel giro di vent’anni butterà fuori dalla filiera più ricca del mondo, quella dell’energia, i Paesi in via di sviluppo.
Non solo. Come osserva correttamente il professor Prodi, imporre vincoli ambientali sempre più stringenti alle nostre aziende significa metterne in crisi la competitività e incentivarne la delocalizzazione, visto che nel resto del mondo queste restrizioni non esistono e le imprese non scontano costi di adeguamento.
L’unica soluzione, perciò, sembrerebbe quella di imporre dei dazi doganali (carbon border tax) su tutte le merci provenienti da Paesi che non rispettano gli standard ambientali europei. In poche parole, un incentivo negativo: se non ti adegui paghi la differenza rispetto a chi si è adeguato.
Il problema, però, è che i Paesi in via di sviluppo hanno sistemi produttivi ad alto impatto ambientale perché sono poveri, non per scelta. E infatti poche settimane fa il plenipotenziario ambientale dell’Amministrazione Biden, John Kerry, ha ammonito l’Unione Europea dalle colonne del Financial Times, invitando alla cautela prima di imboccare la strada del protezionismo verde.
Cerchiamo di illustrare un caso pratico.
Alla fine del 2020 la Commissione Europea ha approvato la nuova strategia agroalimentare dell’Unione, che ha preso il nome di Farm to Fork. Questo nuovo pacchetto di misure e incentivi volto a ridurre l’impiego di prodotti chimici in agricoltura e a stimolare la produzione biologica renderà il settore agricolo europeo molto più chic ma anche molto meno produttivo: il ministero dell’agricoltura americano (USDA) stima che il programma Farm to Fork ridurrà la produzione alimentare dell’Unione Europa del 7/12%, causando un aumento dei prezzi sui mercati globali del 9%, che condannerà alla fame 22 milioni di persone. Addirittura, se tutto il mondo si adeguasse agli standard comunitari il conseguente tsunami sui mercati internazionali delle commodities alimentari condannerebbe alla fame 185 milioni di persone.
Tra l’altro, questa non sarebbe neanche la prima volta che l’Occidente, giocando con l’agricoltura in nome dell’ambiente, affama il mondo.
L’andamento dei prezzi delle derrate alimentari a livello globale
(1990-2020)
Fonte: FAO
A cavallo tra gli anni ’90 e i primi anni del 2000 un compatto schieramento bipartisan che spaziava da Al Gore a George Bush Jr. spinse il Congresso USA ad approvare nuove misure a sostegno della produzione di biocombustibili. I biocombustibili sono combustibili di origine biologica, che quindi hanno un impatto trascurabile a livello climatico. Si estraggono dai semi oleosi (lino, soia, girasole) ma anche dal mais. Come conseguenza, nel giro di due anni il 40% della produzione di mais negli USA fu sottratta al mercato alimentare e destinata alla produzione di biocombustibile. I prezzi delle derrate alimentari sui mercati globali schizzarono scatenando, o contribuendo a scatenare, crisi umanitarie devastanti ai quattro angoli del pianeta.
L’onda lunga delle crisi alimentari del 2007-2008 e del 2010-2012
È chiaro, perciò, che se non vogliamo trasformare la lotta al cambiamento climatico in un genocidio di poveri dobbiamo valutare con molta attenzione le conseguenze delle nostre politiche. E, almeno per il momento, questa dimensione problematica rimane fuori dai radar dell’opinione pubblica e degli attivisti.
Oltretutto, questa transizione non comporta solamente degli evidenti problemi etici ma anche strategici. La Russia rimarrà a guardare mentre la politica energetica euro-americana sgretolerà progressivamente le fondamenta del suo status di superpotenza? L’Arabia Saudita, che custodisce i luoghi sacri dell’Islam, come riuscirà a mantenere la stabilità interna senza i proventi di Aramco? Saranno più imponenti i flussi migratori legati al prosciugamento del lago Chad o quelli legati al prosciugamento delle rendite petrolifere nigeriane? In un mondo attraversato da sempre più conflitti e tensioni per quanto tempo la transizione ecologica potrà restare una priorità strategica? Se la crescita economica nei Paesi in via di sviluppo si raffredderà improvvisamente, a chi venderanno merci e servizi le multinazionali occidentali? E, se le economie avanzate entreranno in una fase di prolungata stagnazione economica, come faranno i governi a chiedere agli elettori sempre più sacrifici in nome dell’ambiente?
Se le nostre intenzioni sono realmente quelle di mettere al sicuro le prossime generazioni varrebbe la pena di farsele queste domande.
Per di più, non ci possiamo concedere il lusso di ignorare la fisica.
L’energia solare, abbondante e rinnovabile, è però venti milioni di miliardi di volte meno densa del petrolio. Venti milioni di miliardi di volte.
Le conseguenze pratiche di questo divario abissale sono significative: per alimentare 130.000 auto tradizionali basta un pozzo petrolifero, quindi una struttura 40 metri per 10, mentre per alimentare 130.000 auto elettriche serve un parco fotovoltaico grande come 1.000 campi da calcio (calcoli basati sul più grande impianto fotovoltaico italiano, quello di Troia, in Puglia). Non solo: mentre per estrarre petrolio – tecnicamente – basta fare un buco per terra, per estrarre energia dalla radiazione solare servono dispositivi tecnologici complessi, materie prime rare e una filiera più articolata di quella di un computer.
I Paesi coinvolti nella filiera di un computer laptop
Fonte: Sourcemap
Questo non comporta solamente costi crescenti e un problema di sostenibilità per il nostro modello di sviluppo, che si basa sull’abbondanza energetica. Significa anche un grosso rischio.
Cerchiamo di non dimenticare, infatti, quello che dovrebbe essere al centro delle nostre preoccupazioni e delle nostre riflessioni quando parliamo del cambiamento climatico: l’incertezza. Con il nostro sassolino, infatti, abbiamo scatenato una valanga di cui non comprendiamo bene neanche le proporzioni.
Pochi mesi fa, su Nature, è arrivata la conferma che lo scioglimento del permafrost ha iniziato ad autoalimentarsi, diventando irreversibile. A sua volta lo scioglimento del permafrost impatta sull’equilibrio delle torbiere, che si stanno inaridendo. Parallelamente, da anni si moltiplicano su tutte le principali riviste scientifiche mondiali appelli concitati sulla salute delle foreste: dall’Amazzonia all’Africa Centrale, le foreste pluviali si stanno seccando. Anche dello scioglimento si affaccia periodicamente sulle pagine delle riviste specializzate ma raramente viene sottolineato che, oltre a far aumentare il livello degli oceani, farà accelerare il riscaldamento globale di almeno mezzo grado.
Ora: le torbiere stoccano permanentemente 1.500 miliardi di tonnellate di CO2, l’equivalente di 40 anni di emissioni nette umane (valori del 2019). Le foreste pluviali 1.700 miliardi tonnellate, quindi l’equivalente di 50 anni di emissioni nette umane. Il permafrost 5.000 miliardi di tonnellate, pari a più di un secolo di emissioni nette umane. E gli oceani imprigionano la stupefacente quantità di 130.000 miliardi di tonnellate di CO2, quindi l’equivalente di 3.500 anni di emissioni nette umane.
Altro che contenimento dell’aumento della temperatura entro due gradi! Il mondo marcia a tappe forzate verso quello che l’IPCC definisce lo scenario Hothouse Earth, quindi verso un aumento della temperatura globale compreso tra 4 e 5 gradi. Un’opzione che la complessità della nostra civiltà non ci permettere neanche di prendere in considerazione.
Non è più tempo di una strategia di contrasto passiva. Non sarà sufficiente azzerare le emissioni, dovremo togliere la CO2 dall’atmosfera.
Questo è l’aspetto più contraddittorio e meno approfondito della lotta al cambiamento climatico: già oggi, con una tecnologia poco più che pionieristica (made in Harvard, finanziata da Bill Gates e revisionata dall’Accademia delle Scienze USA, quindi una cornice ultra-istituzionale), catturiamo una tonnellata di CO2 con 2 MWh di energia, a un costo di 78 euro. Le più moderne centrali a gas emettono una tonnellata di CO2 ogni 4 MWh, una centrale a carbone con Carbon Capture and Storage emette una tonnellata di CO2 ogni 10 MWh, una centrale nucleare è carbon neutral (non emette CO2). In poche parole: già oggi potremmo usare i combustibili fossili, e a maggior ragione l’energia nucleare, per invertire – non rallentare, invertire – il processo che sta trasformando il nostro pianeta in una serra. Per di più, potremmo trasformare la cattura diretta nel settore petrolifero di domani, dato che il processo sviluppato dall’università di Harvard non destina la CO2 allo stoccaggio sottoterra ma la trasforma in combustibile sintetico (tutto incluso nei 78 euro la tonnellata).
Capite bene che si tratterebbe di una rivoluzione copernicana, soprattutto dal punto di vista filosofico: ci siamo convinti che il cambiamento climatico comporterà un radicale cambiamento del nostro modello di sviluppo mentre, in realtà, potrebbe accelerarlo, esattamente come tutte le grandi sfide vinte negli ultimi due secoli.
Per di più, sarebbe una strategia di contrasto al cambiamento climatico che ci darebbe molte più garanzie di quella attuale. Niente variabili culturali, sociali, politiche, nessun impatto sulla catena del valore globale, sui rapporti di forza e sulla competitività industriale. Persino la questione economica si potrebbe risolvere con ripercussioni minime sui consumatori, attivando il Fondo Monetario Internazionale e la World Bank, oppure creando un’istituzione internazionale ad hoc.
Insomma, se non vogliamo rischiare una condanna senza appello dal tribunale della Storia dobbiamo ampliare necessariamente il nostro punto di vista sulla crisi ambientale. E smettere di parlare solo di soldi.