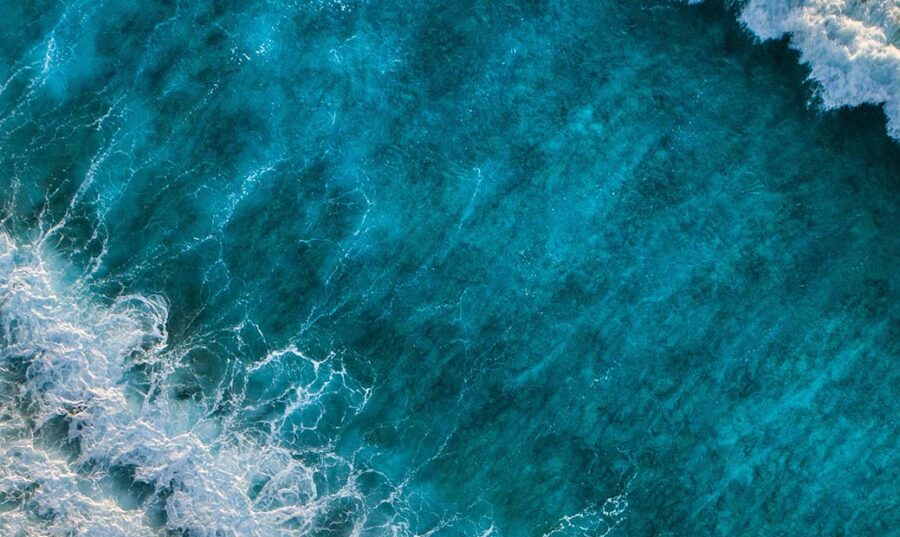L’exploit dei Verdi alle elezioni europee ha consacrato la tematica ambientale e con essa la sua giovane
paladina, Greta Thunberg.
Il messaggio green è intuitivo, accattivante e, perché non essere sinceri, anche modaiolo.
Questo messaggio, però, galleggia su una clamorosa inconsistenza logica e culturale.
Partiamo da una semplice domanda: l’uomo sulla Terra è ospite o padrone?
La Storia inizia quando, circa 6.000 anni fa, le prime comunità organizzate decidono di prendere il controllo di quei fiumi irrequieti da cui dipendeva la loro sopravvivenza, imbrigliandoli in una fitta rete di canali e bacini artificiali. Quando l’uomo decide che il suo destino non può essere in balia delle ondate di piena, regolate dai capricciosi cicli stagionali. Quando comprende che può imporsi sulla Natura.
E da quel momento non ci siamo più fermati.
Quasi 4.000 anni dopo, agli albori della civiltà occidentale, Platone e Aristotele elaborano la scala naturae,
l’ordine di tutto ciò che esiste, ponendo al vertice dell’ordine naturale la creatura più complessa: l’uomo. E
in ragione di questo primato, sanciscono il predominio dell’uomo sulla Natura.
Una prospettiva che ci ha accompagnato nel corso dei millenni, da cui discendono la teoria dell’evoluzione e il sequenziamento del genoma umano, le missioni Apollo e gli acceleratori di particelle, la Carta dei diritti dell’uomo e le Costituzioni.
Alla fine degli anni ’60, però, il primato dell’uomo viene messo improvvisamente in discussione.
Dopo vent’anni di boom economico, la critica sociale al Capitalismo si era indebolita notevolmente in quasi tutte le democrazie occidentali. Ogni anno decine di milioni di americani ed europei diventavano piccolo-borghesi, e concetti come la lotta di classe o la dittatura del proletariato apparivano sempre meno attuali.
L’Unione Sovietica, inoltre, aveva mostrato chiaramente il suo lato oscuro: il muro di Berlino, Budapest,
avevano fatto tramontare il sogno che a Est stesse sorgendo un modello di sviluppo più etico di quello
capitalista.
Gli intellettuali anticapitalisti, perciò, si misero alla ricerca di nuove parole d’ordine in grado di mobilitare le masse. E incapparono in un cavallo vincente: l’ambientalismo.
È bene essere chiari: al netto di qualche esagerazione – assolutamente emendabile alla luce del progresso
delle conoscenze scientifiche – gli allarmi ambientali erano e rimangono più che giustificati. Il problema,
però, è che molti teorici dell’ambientalismo hanno trasformato la penuria di risorse, le piogge acide, il buco dell’ozono e il cambiamento climatico in manifestazioni del medesimo problema: il modello di sviluppo fondato sulla crescita economica, sul benessere diffuso, sullo sviluppo tecnologico e sui consumi di massa.
Nell’immaginario ambientalista, infatti, l’umanità sta combattendo una guerra contro sé stessa.
I nostri stili di vita, la nostra ingordigia, la nostra incuria ci stanno portando all’autodistruzione.
Siamo sull’orlo del baratro ma ci siamo arrivati sulle nostre gambe, è una nostra scelta se precipitare
nell’abisso o tornare indietro sui nostri passi. In definitiva, l’uomo è causa del suo male perché è padrone
del suo destino. Al di là delle apparenze, una visione rassicurante.
In realtà, infatti, l’uomo brancola nel buio. Non sappiamo da dove veniamo e non sappiamo dove stiamo
andando.
Quando all’inizio del XIX secolo l’industrializzazione muoveva i primi passi in Nord Europa, nessuno aveva
idea dell’impatto dei processi di combustione sul clima. L’umanità ha inaugurato l’era dei combustibili
fossili per caso, cercando una via di fuga da condizioni di vita degradanti.
E quando – quasi due secoli dopo – ci siamo resi conto che anche quel modello di sviluppo aveva un costo implicito potenzialmente catastrofico, eravamo già pericolosamente vicini al punto di non ritorno.
Uno schema ricorrente nella storia umana: ciò che distruggiamo per emanciparci dalle nostre paure ritorna sotto forma di fantasma per perseguitarci. Un ciclo continuo di consapevolezza e inconsapevolezza, in cui per sfuggire a un pericolo noto incappiamo in uno ignoto.
Nel frattempo, però, progrediamo.
Negli ultimi 200 anni, mentre pompavamo centinaia di miliardi di tonnellate di anidride carbonica
nell’atmosfera, l’aspettativa di vita media è passata da 30 a 72 anni. La popolazione mondiale è aumentata di 8 volte. Il tasso di povertà è sceso da oltre il 90% a meno del 10%. E anche l’analfabetismo ha seguito una traiettoria analoga. Risultati strabilianti, soprattutto se comparati con quelli dei millenni precedenti. Questo stesso modello che dovremmo ripudiare con disprezzo ha permesso a miliardi di individui, più di quanti ne fossero mai vissuti in tutta la storia del genere umano prima di allora, di condurre una vita incomparabilmente meno “spiacevole, grezza e breve” di quanto avessero mai fatto i loro antenati.
I combustibili fossili sono stati l’ascensore che ci ha proiettato dal “mondo del pressappoco all’universo
della precisione”, il grimaldello con cui abbiamo spezzato le catene che ci impedivano di vivere in mezzo
all’abbondanza, come postulava laconicamente Malthus a inizio ‘800.
Allargando la prospettiva, quindi, è chiaro che l’uomo non ha nessun debito di riconoscenza con il pianeta. Sostenere il contrario presuppone dei limiti che non abbiamo il diritto di superare e quindi una concezione mistica della realtà, che la modernità ha ripudiato come oscurantismo.
Ed è un grave errore confondere questa concezione con quella di chi, ragionevolmente, vuole evitare che la Terra diventi un sasso inabitabile, che la ricchezza naturale del pianeta venga dissipata inutilmente o che le altre forme di vita intelligenti vengano lasciate scomparire nell’indifferenza generale. Lasciando, però, al centro degli sforzi umani l’uomo, la sua salute, il suo benessere, i suoi sogni, le sue angosce e le sue contraddizioni, il suo amore per la bellezza, la sua empatia per tutto ciò che è vivo. E ricordando che quelle stesse specie che vorremmo preservare, quegli stessi ecosistemi che vorremmo proteggere, vengono spazzati via ciclicamente dalla Natura stessa, in nome di quell’equilibrio a cui ci siamo ribellati sin dagli albori della civiltà.
Non c’è motivo, perciò, perché la lotta al cambiamento climatico ci conduca su un sentiero di penitenza,
alla ricerca del perdono per chissà quale colpa. L’ordine che abbiamo sovvertito bruciando carbone e
petrolio o mangiando carne è lo stesso ordine che mettiamo in discussione quando ci vacciniamo o diamo l’antibiotico ai nostri figli. Anzi, a dire la verità, è proprio quella la radice del problema che abbiamo con il pianeta: non dovremmo sopravvivere in così tanti all’infanzia, non dovremmo essere così resistenti alle malattie e, in definitiva, non dovremmo vivere così tanto. Se fossimo molti meno, non avremmo bisogno di trattori, fertilizzanti e diserbanti per assicurarci più cibo di quanto naturalmente ne generi la terra, non avremmo bisogno delle fabbriche per produrli ed emetteremmo molta meno anidride carbonica. Se poi, 9 su 10 fossero poveri, avremmo risolto anche il problema del trasporto privato e del riscaldamento.
Ma nessuno ha il diritto di chiederci di rallentare, o addirittura arrestare, la nostra corsa verso la libertà: la libertà dai bisogni materiali, la libertà dalle malattie e, alla fine del tunnel, la libertà dalla morte.
La nostra esperienza millenaria ci ha insegnato che c’è sempre un’altra possibilità. E i nostri libri di Storia
ricordano coloro i quali hanno imposto sacrifici alla propria comunità “per il bene di tutti” come fanatici,
integralisti o, nel peggiore dei casi, genocidi.
Il cambiamento climatico è una sfida da cui dipende il nostro futuro. Ma, come tutte le grandi sfide che
abbiamo affrontato in passato, è anche una grande occasione. Non certo di farci più piccoli ma di diventare più grandi.
La scienza e la tecnologia, le nostre alleate più fedeli nella fuga dall’impotenza, ci hanno messo a
disposizione tanti strumenti per prendere il controllo del clima. Alcuni rudimentali e poco incisivi, come
l’imboschimento e il rimboschimento, che potrebbero aumentare gradualmente ma limitatamente la
capacità di assorbimento dell’ecosistema terrestre. Altri fantascientifici, come i sistemi di controllo
dell’irraggiamento terrestre, che promettono di mettere in mano all’umanità il termostato del pianeta ma
che sono ancora in una fase di sviluppo pionieristica e potenzialmente pericolosa. Altri ancora, efficaci e
affidabili, come i sistemi di cattura diretta dell’anidride carbonica in atmosfera, che filtrano l’aria
depurandola dalla CO2.
Quest’ultima soluzione in particolare ci garantirebbe una prima forma di controllo sul clima, seppur
indiretta. Con capacità di cattura adeguate, infatti, avremmo la possibilità di controllare il livello di anidride carbonica nell’atmosfera e quindi di regolare uno dei parametri fondamentali del sistema climatico terrestre.
Fino a due anni fa il riferimento nel settore era ClimeWorks, un’azienda spin-off svizzera che cattura
l’anidride carbonica a 600 dollari la tonnellata. Una cifra fuori mercato, almeno per il momento. Tuttavia, a
giugno 2018 David Keith, professore di fisica applicata all’Università di Harvard, ha presentato i dati di un
nuovo impianto pilota che adotta uno schema di cattura alternativo, ribassando le stime dei costi a 94/232 dollari la tonnellata. L’impianto è stato realizzato da Carbon Engineering, startup fondata dallo stesso Keith e finanziata da Bill Gates. Il paper è stato pubblicato sulla rivista Joule, neonata sister journal di Cell, una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo. La NASEM (Le Accademie Nazionali di Scienze, Ingegneria e Medicina), una delle istituzioni scientifiche più autorevoli del pianeta, ha revisionato pochi mesi fa il processo e, pur avanzando qualche perplessità sui calcoli di Keith, ha concluso che attualmente è possibile catturare l’anidride carbonica direttamente in atmosfera a circa 90 dollari la tonnellata (p. 365).
Il 23 maggio la Occidental Petroleum, una compagnia petrolifera texana, ha annunciato la costruzione nel
bacino Permiano di un impianto di cattura da 500.000 tonnellate l’anno, in collaborazione con Carbon
Engineering. E nei prossimi anni sono previsti altri moduli da 1 milione di tonnellate l’anno.
Paradossalmente, l’anidride carbonica catturata verrà iniettata nei giacimenti per aumentare la produzione di greggio. Uno dei pochi utilizzi che garantisca un ritorno economico, almeno per il momento. La CO2, però, rimarrà stoccata permanentemente nel sottosuolo.
Il passaggio è fondamentale: si tratta dei primi impianti su scala industriale.
Solo per dare un’idea delle potenzialità delle economie di scala: il costo di una cella fotovoltaica (silicio
monocristallino) è diminuito di 250 volte negli ultimi 40 anni e si è più che dimezzato negli ultimi 6.
Nonostante la tecnologia e i processi di produzione siano rimasti, sostanzialmente, invariati.
Non solo: le stime attuali non prevedono il coinvolgimento diretto del settore pubblico, né nel processo di finanziamento né durante la gestione degli impianti. Proprio per questo motivo, facendo affidamento sulle sovvenzioni come tutti i privati del settore, gli investitori inseguono i programmi di incentivazione più vantaggiosi piuttosto che le condizioni di mercato più favorevoli (costo della manodopera, costo
dell’energia etc). Inoltre, sono costretti a finanziarsi alle condizioni di mercato, e quindi con un costo del
7,5%/10,5% annuo. In sostanza, già oggi, i costi reali sono molto più bassi di quelli di riferimento.
Una prospettiva entusiasmante, tenendo conto che le stime ufficiali prevedono migliaia di miliardi di dollari di investimenti l’anno per il contrasto del cambiamento climatico e che l’uomo emette circa 45 miliardi di tonnellate di anidride carbonica l’anno.
Oltretutto, si tratta di una tecnologia che non si pone in antitesi alla quinta rivoluzione industriale, quella
delle fonti rinnovali. Anzi, ha un notevole potenziale sinergico. Per ottimizzare l’efficienza del ciclo di
cattura, infatti, gli impianti devono essere alimentati necessariamente da fonti di energia pulite e quindi lo
sviluppo della capacità di cattura procederebbe di pari passo con l’aumento della domanda di energia
fotovoltaica, eolica, termodinamica.
Una tecnologia che non deve sottrarre risorse allo sviluppo di reti integrate e intelligenti, alla
riqualificazione edilizia o all’efficienza energetica ma che può essere estremamente utile per compensare i
ritardi nei settori più resilienti alla transizione verso nuove forme di alimentazione, come i trasporti,
l’industria energy intensive e low-tech o l’economia di sussistenza.
Perché, allora, la cattura diretta ha tante difficoltà ad affermarsi come game changer nella lotta al
cambiamento climatico?
Perché la crescente inquietudine eco-ambientale, giustificata e comprensibile, è stata incanalata in una
controcultura che l’ha trasformata in un’arma con cui combattere una battaglia ideologica. Gran parte degli ambientalisti, consapevolmente o inconsapevolmente, non stanno cercando una soluzione al problema ma la prova definitiva che avevano ragiona sin dall’inizio: questo modello di sviluppo è perverso e va cambiato.
E sono pronti a un pericoloso braccio di ferro con le classi popolari, per il momento ostili a cambiamenti
radicali dello stile di vita, pur di raggiungere il loro scopo.
L’entusiasmo con cui le élites progressiste stanno salutando l’avvento di questa onda verde, quindi, è del
tutto ingiustificato. Per il momento, i movimenti ambientalisti sembrano l’ennesimo prodotto di un periodo confuso e in lotta con la sua tradizione culturale, che però non è in grado di sostituire.